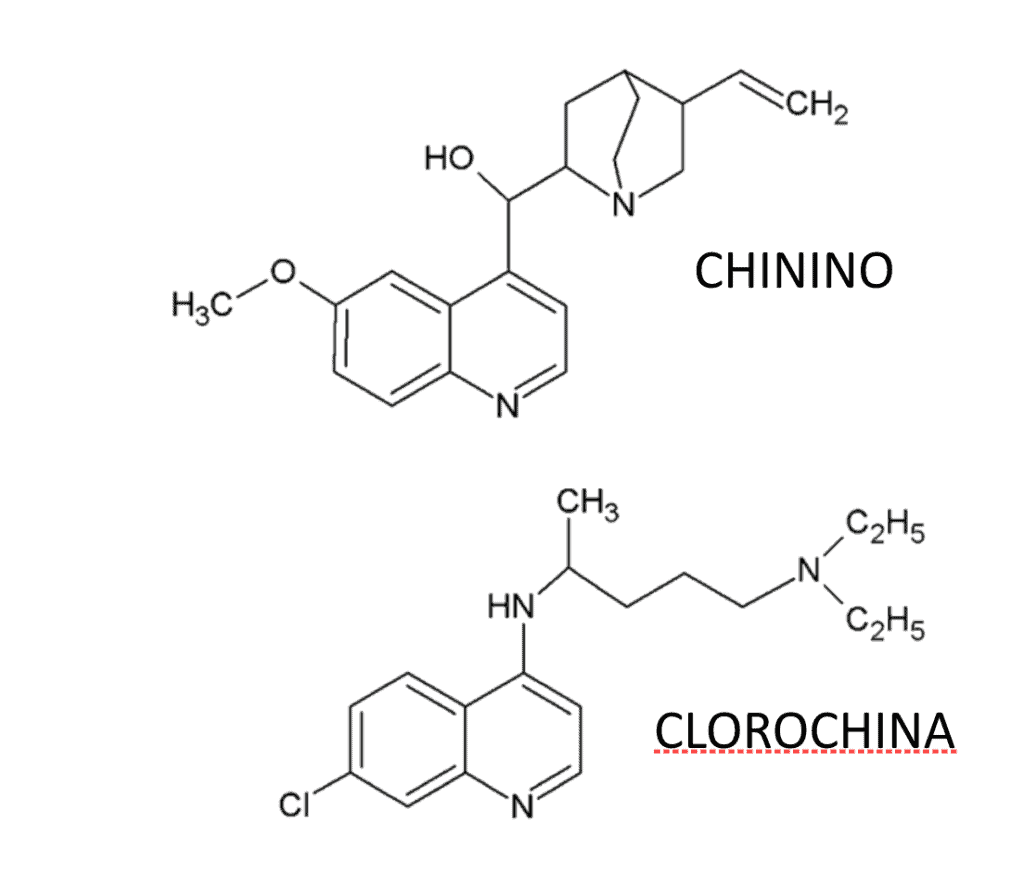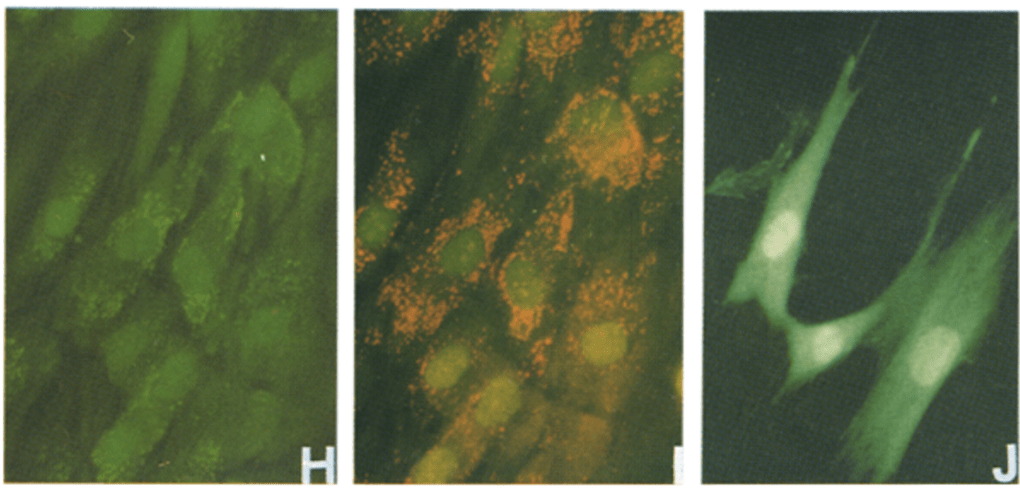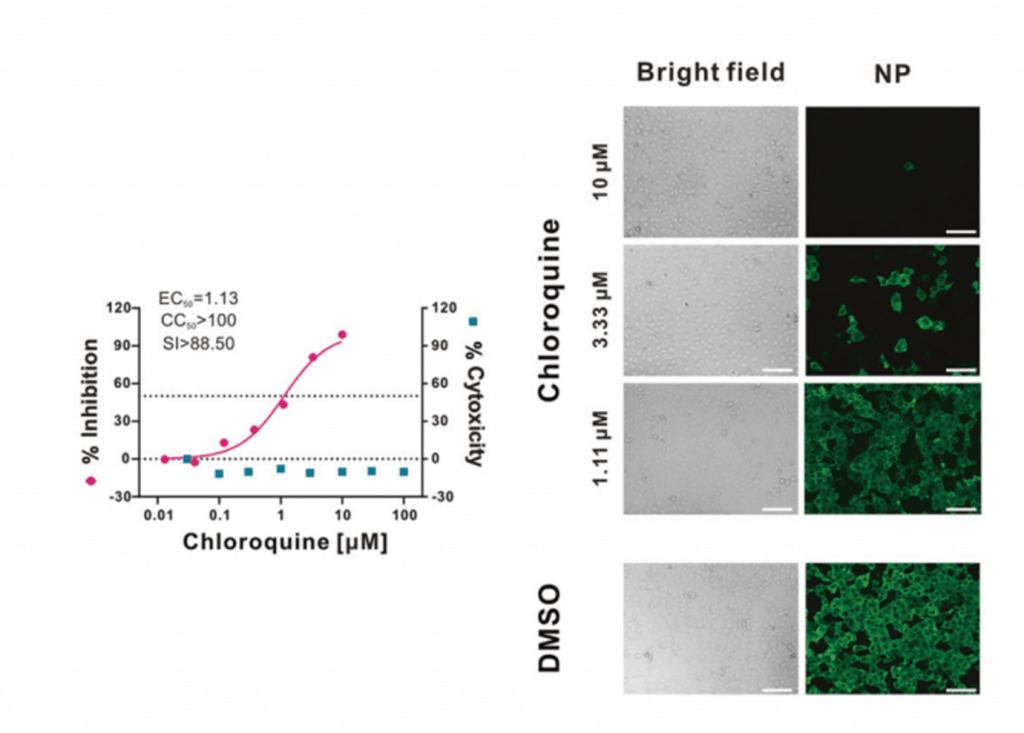Presidente di BrainCircle Italia
Un amico mi ha inviato una fotografia che lo ritrae con la sua compagna, vestiti da sera, il tavolo imbandito per una cena elegante.
Un altro, le immagini della sua casa piena di fiori freschi (si è messo d’accordo con un fiorista che glieli recapita ogni giorno fuori dalla porta). Mi hanno fatto riflettere sull’importanza di voler bene. Agli altri, ma soprattutto a se stessi. Chiusi in casa, ansiosi, sopraffatti dalle cattive notizie, con la sensazione che il cerchio si stringa intorno a noi (chi non ha un amico, un conoscente, un familiare positivo?), tendiamo a lasciarci andare, a trascurarci. Perché farsi belli, se tanto non si può uscire? Perché agghindare la casa, che è diventata la nostra prigione? E invece, quei gesti di cura fanno bene allo spirito. “La bellezza salverà il mondo”, lo ha detto magistralmente Dostoevskij. Ben lo sapevano i musicisti che fino all’estremo delle loro esistenze suonavano e componevano nei campi di concentramento: un gesto per ribadire la loro umanità contro chi voleva trasformarli in numeri. Ricordo l’anziana nonna di una mia cognata, vedova, che viveva sola a Camogli, sempre sorridente e radiosa. “Mi curo la pelle con prodotti naturali, cucino prelibatezze tutti i giorni, e apparecchio la tavola con la tovaglia di lino: sto bene perché mi voglio bene” mi confidò. È vissuta serena fino a novant’anni.
Amore è accettare le restrizioni cui siamo chiamati con responsabilità di se stessi e degli altri. Il ministro della salute israeliano, Naftali Bennet, in una intervista diffusa sui social, spiega che l’amore per i nonni è stare lontani, non facendo mancare la propria presenza virtuale e sollecitudine.
Amore è fare una telefonata agli amici che sappiamo essere soli.
Amore è un sorriso. Scambiarsi battute, vignette umoristiche, ridere, è un toccasana. Perché ci distrae per un attimo dai pensieri negativi, e perché stimola la produzione di endorfine, i neurotrasmettitori del piacere, che contrastano il cortisolo prodotto dall’ansia e riequilibrano il nostro sistema immunitario.
“E sia benedetto l’umorismo, il miglior modo di affrontare tutto questo. Quando riusciamo a ridere del Covid-19 proclamiamo, di fatto, che non siamo completamente paralizzati. Che abbiamo ancora libertà di movimento. Che continuiamo a combattere e non siamo vittime indifese (in realtà lo siamo, ma abbiamo trovato un modo di aggirare questa orribile consapevolezza, e persino di riderne)”.
Sono le parole che lo scrittore David Grossman ha pubblicato in un suo recente intervento sul Corriere della Sera. E che sintetizzano in poche righe l’essenza dell’umorismo ebraico, la witz. Un umorismo straordinario, sul quale sono stati scritti libri, realizzati spettacoli, e che Woody Allen ha portato in modo superbo sullo schermo. È la capacità di ridere di se stessi, delle proprie disavventure e persino disgrazie, nella consapevolezza che la vita è incerta e spesso crudele, che la felicità, quando c’è, è transitoria, il destino quasi sempre riserva sofferenza, persecuzioni, calamità, e l’unico modo di difendersi è relativizzare e sorridere. È l’umorismo di un popolo perseguitato e perdente, che sa che le vere vittorie sono quelle dello spirito.
Ogni cultura ride a modo suo. Gli italiani sono i più fantasiosi: canzoni, imitazioni, sketch. L’incontenibile Crozza. Aldo Giovanni e Giacomo con i loro viaggi immaginari. Totò riscoperto. Le serenate sui balconi. Il Nabucco cantato da un coro virtuale. Le bellezze del Paese con l’Inno di Mameli come colonna sonora. I francesi mettono in rete la Monna Lisa che finalmente riposa, o una modella sexy che ricava la mascherina dal triangolo del reggiseno… Gli americani non hanno bisogno di comici perché hanno Trump, ogni giorno una risata, segnalo la canzone “New York, New York” riscritta su di lui – una supercarica di endorfine, almeno per me – o il calendario delle sue dichiarazioni sul Covid-19, ognuna sul relativo quadratino del giorno in cui l’ha pronunciata, a partire da: “abbiamo tutto sotto controllo” a fine gennaio, “appena fa caldo finisce tutto” a metà febbraio (immagino che in California abbiano tirato un sospiro di sollievo), “presto arriveremo a zero casi” (fine febbraio), “avremo vaccini prestissimo e anche terapie” (inizio marzo), “siamo stati bravissimi” (metà marzo) fino a “questa è una pandemia, l’ho sempre detto” pochi giorni fa. Ridere per non piangere…
Gli inglesi non rinunciano alle freddure: aereo pieno zeppo, la voce dello speaker annuncia: “Buongiorno, sono il vostro pilota. Oggi lavoro da casa…” Il premier spagnolo annuncia: “Una buona notizia: l’infedeltà è scesa del 99,9%”.
Il Paese che forse produce l’umorismo più caustico è Israele. Tra le prime barzellette che ho ricevuto, questa, subliminale, di matrice tipicamente yiddish: “Rabbino, qual è la dieta che lei consiglia in caso di coronavirus? Il pane azzimo, ovviamente. Ovviamente perché? Perché scivola facilmente sotto la porta”.
Ma il nuovo umorismo israeliano pur avffondando le radici nell’ironia yiddish è molto diverso dalla tradizione. Lo spiega la giornalista Viva Sarah Press in un lungo articolo apparso sul suo blog: “è un umorismo cinico, senza barriere, un umorismo dark che si è sviluppato sotto i bombardamenti dei razzi, gli attacchi terroristici, le continue minacce di guerra” sostiene. Bersagli preferiti il governo e le misure di sicurezza (“saluta il Shin Bet, ormai è parte della nostra conversazione” è apparso subito dopo l’annuncio che i Servizi tracceranno gli spostamenti attraverso i cellulari). Tra i bersagli preferiti il Ministero dell’Istruzione ”il cui sito web continuamente va in tilt perché non è un sito porno e quindi non è abituato ad avere così tanti utenti contemporaneamente”, preso di mira per aver mandato gli insegnanti a casa nel divertente sketch dell’insegnante Shiri Kenisberg Levi, diventato virale in poche ore, nei panni di una madre con i figli a casa. “Se non moriremo di coronavirus moriremo di insegnamento a distanza” sbotta dopo un minuto e mezzo di improperi.
“Una sana risata aiuta a mettere tutto in prospettiva e, trascinandoci in una diversa zona emotiva, può aiutarci a ristrutturare i nostri pensieri negativi” sostiene Jeff Gordon, clown therapist e fondatore di un programma di Happiness Training, l’allenamento alla felicità.
In questo momento ne abbiamo proprio bisogno. E i social sono di grande aiuto. Avete notato? Ai selfies, alle blaterazioni dei no vax (finalmente zitti e in spasmodica attesa di un vaccino) si è sostituita una rete di solidarietà, di persone che offrono lezioni di yoga o di meditazione, consegne a domicilio, momenti di socializzazione, lezioni di bridge, book clubs, sostegno psicologico ed entertainment musicale (sublimi La Scala e il Met che mettono in rete le opere più belle).
E se volete finire con un sorriso, andate a cercare l’Agenda da #Quarantena pubblicata da Paolo Camilli su Instagram: irresistibile, un accurato ritratto di ciò che sta succedendo in rete.
di Viviana Kasam