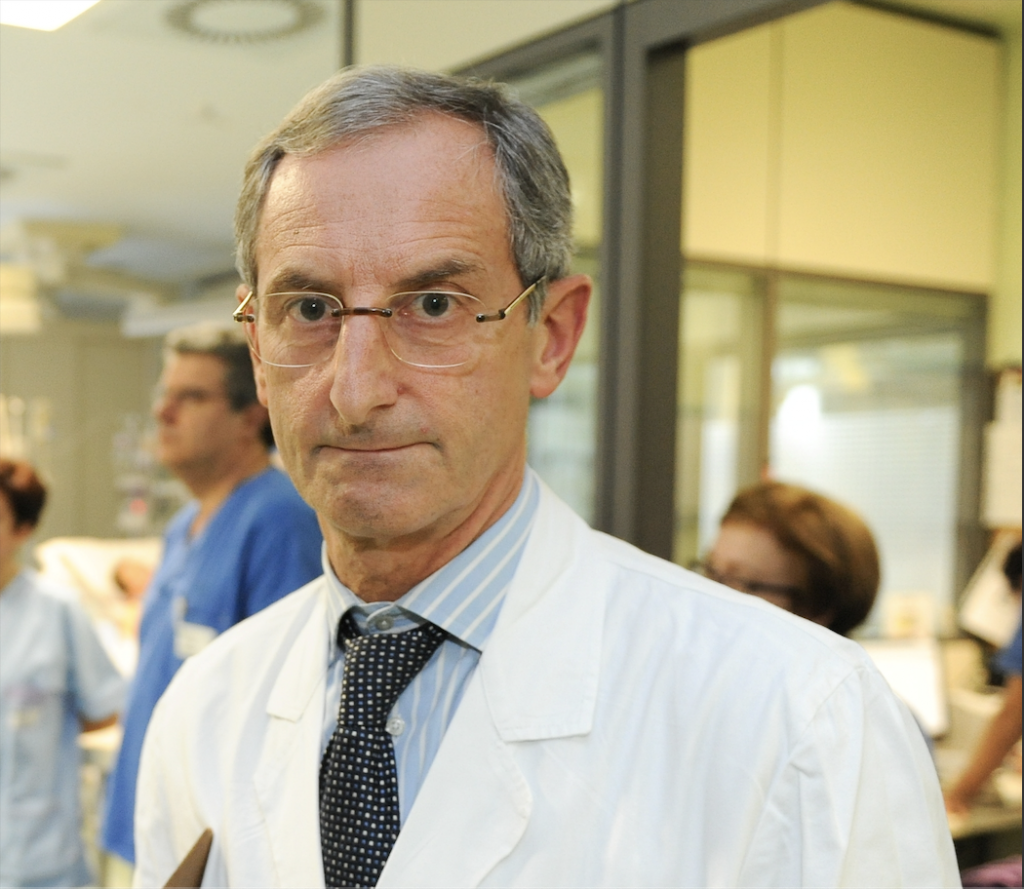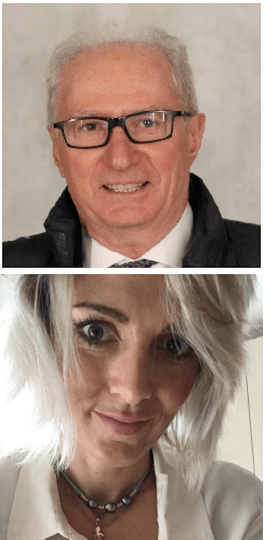Vorrei consigliare la lettura di due testi di Agnes Heller che considero importanti per la formazione degli insegnanti e per la didattica sui Giusti che stiamo impostando con la Commissione didattica di Gariwo per le scuole italiane.
Si tratta de La bellezza della persona buona (Diabasis), una raccolta di saggi, e Il male radicale (Castelvecchi editore), testo che presenta i suoi ultimi interventi.
Agnes Heller ha il grande merito non solo di avere prodotto una riflessione filosofica originale e di avere sempre affrontato nella sua vita i temi fondamentali del nostro tempo, ma anche di essere sempre molto chiara e sintetica.
Quando l’ho incontrata per l’ultima volta a Milano, in una cena dopo una conferenza che avevamo organizzato insieme al nostro amico Francesco Cataluccio ai Frigoriferi Milanesi, mi era sembrata una ragazzina per lo spirito e la forza che metteva nella sua conversazione. Eravamo tutti stanchi per una giornata ricca di impegni, ma Agnes Heller continuava a farci domande e ci trasmetteva tutto il suo amore per i giovani.
“Se non vi seguono – rideva in un tavolo di insegnanti e di intellettuali – non dipende da loro, ma dal vostro linguaggio. Siete voi che non siete adeguati”.
Mi raccontò di avere qualche anno prima salvato in mare un suo collega molto più giovane che nuotava con lei a Capri, e ripensare oggi alla sua fine nel lago di Balaton, dove è annegata nuotando da sola, come faceva normalmente, mi suggerisce l’essenza della sua filosofia di vita.
Fino alla fine bisogna sempre osare e lasciare agli altri, anche il giorno prima della scomparsa, il meglio di sé.
Penso per esempio a un grande pianista jazz come Bill Evans, che una settimana prima della sua morte, il 15 agosto del 1980, tenne al Keystone Korner di San Francisco una decina di concerti che non mi stanco di ascoltare perché rappresentano la sintesi della sua genialità musicale.
Agnes Heller continuò a scrivere e a fare bellissime lezioni fino alla fine senza essere mai malinconica. E anche il suo impegno di vita fu sempre coerente. Dalla sua adesione al marxismo critico, allieva del filosofo György Lukács, era passata alla battaglia antitotalitaria nel ’56 ungherese e nel ’68 segnato dall’invasione di Praga. E poi, tornata a Budapest, dopo avere insegnato a New York e in Australia negli anni del suo esilio, ha cominciato una battaglia importante in nome del cosmopolitismo contro il risorgere dei nazionalismi e i fautori della democrazia illiberale – come l’ungherese Victor Orban.
Agnes Heller immagina un viaggio in treno dalla stazione del bene al male radicale. Alla prima fermata non esistono i santi, ma persone che aspirano ad essere buone e che quando sbagliano sono capaci di ammettere i loro errori, senza nasconderli. Si muovono a partire dal principio socratico, secondo cui è meglio subire un torto piuttosto che commetterlo.
Sono le persone migliori e tutti noi possiamo essere come loro, perché è questo il bene possibile alla portata di ognuno.
La stazione successiva comprende l’uomo qualunque, che pure essendo in grado di distinguere il bene dal male, non lo fa, non sceglie il bene perché si lascia trasportare dalle passioni, oppure perché è spinto dal proprio interesse personale.
Probabilmente queste persone, se potessero ottenere tutto ciò che vogliono cercando di fare il bene, sceglierebbero certamente questa seconda strada. Sono persone oscillanti che molto spesso hanno un comportamento contraddittorio. Sanno bene cosa sarebbe giusto fare, ma poi fanno il contrario e provano anche un rimorso di coscienza.
Poi ci sono coloro che non si pongono alcuna domanda e che usano le altre persone per il proprio piacere e per il proprio tornaconto personale. Sono le persone che possiamo definire malvagie. Sono disponibili perfino ad uccidere, a commettere ogni di tipo di reato, per il loro fine egoistico. Penso che tutti noi avvertiamo una sensazione fisica di rigetto quando incontriamo persone nel cui volto possiamo leggere la cattiveria. Sono coloro che feriscono non solo un corpo, ma l’anima e la psiche delle persone. Le troviamo tra i bulli nelle scuole e nello sport, sui social e persino nell’arena politica: sono coloro che provano piacere nel disprezzare e umiliare gli altri con le parole e gli insulti.
Eppure non sono queste ancora le persone più pericolose per un ribaltamento della società poiché possono essere contenute e neutralizzate.
Il pericolo maggiore viene da coloro che teorizzano con le loro massime il valore del male e ci dicono: puoi uccidere, rubare, mentire, usare gli altri, sottometterli. Questi uomini, con ragionamenti sofisticati e parole ambigue, cercano di farci accettare la disumanità come unica via alla sopravvivenza e all’agire su questa terra.
Per certi versi sono peggiori non solo degli opportunisti, ma anche delle persone malvagie, perché iniettano magari con il sorriso, la seduzione, con un comportamento apparentemente rispettoso, il veleno ideologico nella società. Sono diabolici come Satana, sostiene la Heller, non perché commettono atti sbagliati, ma perché inducono gli altri a commetterli, persuadendoli che il male sia giusto.
Ecco perché quando appaiono nella società democratica individui, intellettuali, politici che dichiarano pubblicamente l’antisemitismo, usano parole di disprezzo verso le minoranze e i migranti, teorizzano l’odio, la superiorità dell’uomo sulla donna, disprezzano gli omossessuali, considerano legittimo il terrorismo, bisogna subito reagire. Possono essere l’anticamera di un messaggio pericoloso che invita la società a dare la caccia ai nemici. Non bisogna mai prendere alla leggera chi diffonde massime malvagie. Il salto di qualità avviene infatti quando si crea una società totalitaria dove si realizza un connubio tra valori malvagi (puoi uccidere), passione sadiche (il gusto di umiliare e di perseguitare l’altro) e una seduzione collettiva dove la malvagità diventa attrattiva e contagiosa.
È quello che la Heller definisce come il male radicale moderno. In questo caso una massima individuale malvagia si trasforma in una ideologia collettiva fino a diventare il fondamento di un sistema politico.
Agnes Heller fa i conti con le teorizzazioni di Hannah Arendt sulla banalità del male. Non le rigetta, ma a mio avviso rielabora il concetto.
Certamente in una società totalitaria esistono delle persone che seguono i carnefici per opportunismo, perché si astengono dal pensare, perché ubbidiscono agli ordini e a leggi ingiuste abdicando alla capacità di giudizio personale e alla coscienza. Ma questi comportamenti avvengono in un contesto dove è diventato legittimo uccidere gli esseri umani e dove prevalgono criteri morali che ribaltano i dieci comandamenti. La banalità del male è dunque una fuga dalla propria responsabilità che va studiata e analizzata, ma essa si manifesta sempre all’interno di un male radicale. Comunque, osserva la Heller, anche chi agisce senza pensare, quando si presta ad un omicidio di massa, commette un male che non è mai banale. Chi uccide senza pensare, ubbidendo agli ordini, anche se non convinto ideologicamente dalle massime malvagie, uccide comunque.
Per la Heller è interessante osservare, e qui sono le affinità con la Arendt, che anche chi teorizza le massime malvagie non è sempre un mostro o una bestia assetata di sangue. Si può essere portatori e diffusori di una ideologia che chiede la distruzione dell’altro e poi essere rassicuranti e vivere una vita quotidiana normale senza apparire sadici. Si può essere demoniaci nelle idee e non vivere da demoni. Come del resto non avere in testa idee malvagie e comportarsi da demoni.
Agnes Heller ragiona molto sulla dinamica del genocidio nella modernità, e coglie una differenza fondamentale con il passato. Era per esempio un valore eroico per i Greci distruggere Troia e annientare i suoi abitanti, come del resto lo era per i Romani a Cartagine o per gli ebrei sterminare nel deserto la tribù dei beduini di Amalek, considerati i nemici di Israele. Oggi invece un genocidio non è più considerato eroico, naturale e nemmeno necessario per la propria difesa come nell’antichità, perché facciamo riferimento al principio che tutti gli uomini nascono uguali e hanno senza distinzione il diritto alla vita e alla libertà. Abbiamo quindi dei parametri morali per giudicare.
Eppure questo ideale della modernità può risultare efficace o inefficace.
È efficace se gli uomini credono nella verità della massima, si assumono una responsabilità e agiscono o giudicano gli altri in conformità ad essa.
È soltanto uno slogan di facciata se c’è una adesione solo formale senza una reale applicazione nei comportamenti. Tanti sono i regimi che hanno sottoscritto la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e poi commettono gravi crimini contro l’umanità.
E poi se anche la maggior parte degli uomini nascono liberi, molto spesso preferiscono non fare uso di questa libertà. Non è infatti detto che chi riceve il regalo della libertà rispetto alla condizione di epoche passate ne faccia poi uso. La libertà è sempre una scelta e come sottolinea la Heller è un fondamento che non fonda nulla.
Ma se abbiamo dei criteri per giudicare che non avevano gli antichi, perché il male radicale può abitare il cuore della modernità? La risposta per la Heller va ricercata nella nascita delle ideologie che ribaltano i valori e che sono alla base della nascita dei regimi totalitari.
L’ideologia è una sorta di immaginazione tecnologica. Qualcuno crea uno strumento di dominazione mettendo insieme briciole e frammenti di idee, concetti, religioni e filosofie e lo presenta come le Verità. Ciò che non rientra in questo corpo ideologico è considerato falso e pericoloso e deve essere ridotto al silenzio e persino annientato.
Tuttavia, quando parte questo meccanismo perverso, non si tratta solo di eliminare delle idee dalla circolazione, ma anche le donne e gli uomini che sono considerati portatori di concezioni sbagliate e che ostacolano così il trionfo della verità. Per questo motivo il pluralismo deve essere bandito e sostituito da istituzioni che implementino un pensiero unico. È questo il primo passo che porta alla persecuzione degli uomini e, nelle situazioni estreme, alla loro eliminazione.
Quanto spiegato dalla Heller lo possiamo vedere non solo nei regimi totalitari del passato, ma anche nei meccanismi perversi dei social. C’è spesso un piccolo guru che dopo avere creato una sua tribù di accoliti bombarda la rete con delle affermazioni perentorie che si presentano come la verità assoluta. Non è uno sprovveduto perché presenta le sue opinioni con una tecnica raffinata. Se qualcuno capita per caso in questo gruppo ed esprime un dubbio o un ragionamento sensato non riceve soltanto un rimprovero, ma viene indicato come un nemico e tutti i fan del guru gli vanno contro. Diventa fastidioso non solo per le sue osservazioni critiche, ma come individuo pensante, e per questo partono gli attacchi personali. Deve quindi adeguarsi ed è costretto, per non cadere in una gogna mediatica, a rimanere in silenzio. Altrimenti viene cancellato.
Per Agnes Heller Auschwitz è il simbolo del male radicale della modernità, un evento su cui noi dobbiamo continuare a ragionare e che si può sempre ripetere non nello stesso modo, ma in forme simili.
Lo è stato per il capovolgimento assoluto dei valori tra bene e male con l’ideologia hitleriana; per l’uso sistematico della tecnologia moderna nella realizzazione di un genocidio; per la costruzione di un sistema totalitario; per la tradizione antisemita europea.
Il suo ragionamento però non ha niente a che fare con quello di chi, quando ricorda l’unicità della Shoah, pensa che quel male radicale non possa essere mai paragonato con un altro male.
La filosofa ebrea ed ungherese ci invita a pensare che ogni forma di degenerazione politica, di discorso pubblico con massime malvagie, di limitazione dei diritti democratici, di attacco al pluralismo e al dialogo con una verità ideologica, di ritorno ai nazionalismi, ci potrebbe riportare di nuovo in quel baratro.
L’anticamera del male è sempre un segnale che tutto potrebbe ripetersi.
“Come impedire che si verifichi di nuovo un orrore anche solo simile? La risposta è semplice. Mobilitando tutte le forze mentali, e anche i poteri istituzionali se necessario, contro l’antisemitismo, contro il razzismo in generale, contro i pericoli di qualsiasi totalitarismo e terrore vecchio e nuovo che sia; mettendo in atto tutte le risorse mentali e sociali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, la diffidenza verso le basi psicologiche del totalitarismo, verso i gemelli del nichilismo e del fondamentalismo. È necessario lavorare sull’immaginazione. Affinché tutto ciò sia possibile, serve un mondo in cui i diritti dei cittadini siano riconosciuti dalle leggi, dove i diritti umani siano riconosciuti, dove ci sia liberà di parola e di stampa, serve in definitiva il mondo delle democrazie liberali. Esistono poche democrazie liberali e quelle che esistono subiscono pressioni esterne ed interne”.
Il suo monito vale ancora di più per questi giorni in cui tutta l’umanità, in ogni angolo del globo, è messa a dura prova di fronte alla pandemia.
Se ne potrebbe uscire con una collaborazione internazionale, come si legge sulle nostre pagine nell’intervista allo storico Yuval Noah Harari, o con guerra di tutti contro tutti e la nascita di nuovi regimi totalitari, che potrebbero controllare le persone e decidere chi possa vivere oggi e chi debba essere abbandonato al contagio.
Dimenticare gli anziani, i Paesi più poveri, i migranti nei campi profughi è già stata la tentazione di alcuni governanti. Anche in questa emergenza, assieme a grandi atti di solidarietà, sentiamo parole malvagie e vediamo chi soffia sul nazionalismo, auspica regimi autoritari e ci invita a fare la guerra ai nemici.
di Gabriele Nissim